- Homepage / News / Normativa e Prassi / Cumulo alla rinfusa: dal nuovo Codice dei contratti pubblici al Correttivo
Esclusiva web: prova gratis per 10 giorni
Attivando subito la prova dei nostri servizi potrai utilizzare la piattaforma Telemat per:
- Ricevere avvisi quotidiani sulle nuove gare di tuo interesse
- Analizzare velocemente tutti i documenti
- Ricercare all'interno del nostro archivio
Articoli recenti
- Cumulo alla rinfusa: dal nuovo Codice dei contratti pubblici al Correttivo
- Partenariato Pubblico Privato e Codice appalti (Dlgs 36/2023)
- Il soccorso istruttorio nel Nuovo Codice Appalti: tipologie, limiti e novità
- La Digitalizzazione dei Contratti Pubblici nel Codice Appalti
- L’equo compenso negli appalti pubblici: legge 49/2023
Cumulo alla rinfusa: dal nuovo Codice dei contratti pubblici al Correttivo

L’evoluzione dell’istituto del cumulo alla rinfusa, dall’applicazione generalizzata prevista con l’entrata in vigore del d. lgs. n. 36/2023 fino al suo ridimensionamento generato dal d. lgs. n. 209/2024 (c.d. Correttivo al Codice dei contratti pubblici).
Cos’è il Cumulo alla rinfusa
L’istituto del c.d. “cumulo alla rinfusa” rappresenta un meccanismo che consente ai consorzi stabili di potersi qualificare, cumulando i propri requisiti di capacità tecnica ed economica a quelli maturati dalle imprese consorziate, in una sorta di avvalimento ex lege.
È evidente, dunque, che il cumulo alla rinfusa rappresenti uno strumento, teso al favor partecipationis, inscindibilmente connesso ad una specifica forma di aggregazione di soggetti, vale a dire l’organizzazione d’impresa collettiva di cui all’art. 65, comma 2, lett. d), d. lgs. n. 36/2023, ovvero, appunto, il consorzio stabile.
Tale istituto, tuttavia, è ancor oggi fonte di incertezze a causa del susseguirsi di interventi normativi che ne hanno modificato, ampliandone e poi riducendone, l’applicazione, senza in ogni caso mai dissiparne completamente i dubbi interpretativi ed applicativi.
Ad ogni modo, prima di descrivere la più recente evoluzione dell’istituto del cumulo alla rinfusa - in particolare dalla primigenia formulazione dell’art. 67, comma 2, d. lgs. n. 36/2023, sino a quella attualmente in vigore, risultante dalle modifiche apportate al Codice dal , recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” (c.d. Correttivo al Codice dei contratti pubblici) - occorre definire quello specifico operatore economico, rientrante nel novero dei consorzi non necessari, denominato consorzio stabile.
Definizione e caratteristiche del consorzio stabile
Gli elementi distintivi affinché una specifica cooperazione tra più imprese costituisca un consorzio stabile - e non invece un’altra fra le molteplici forme consortili previste dal Codice dei contratti pubblici - sono tassativamente indicati all’art. 65, comma 2, lett. d), d. lgs. n. 36/2023, secondo il quale i consorzi non necessari in questione sono “costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa”.
L’esame letterale della normativa non lascia adito ad alcun dubbio in merito al fatto che i consorzi stabili siano un’aggregazione di imprenditori individuali e/o di società muniti di un’autonoma personalità giuridica, costituiti da almeno tre consorziate, le quali abbiano stabilito con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi di operare nel settore degli appalti pubblici di lavori, servizi o forniture, per un periodo non inferiore a 5 anni attraverso una specifica e comune struttura aziendale.
Il primo elemento che distingue i consorzi stabili da quelli ordinari - questi ultimi, infatti, sono separatamente disciplinati, unitamente ai raggruppamenti temporanei, all’art. 68, d. lgs. n. 36/2023 - è la loro “autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate”, che li rende delle “aggregazioni durevoli di soggetti che nascono da un’esigenza di cooperazione ed assistenza reciproca e che, operando come un’unica impresa, si accreditano all’esterno come soggetto distinto” (Cons. Stato, sez. III, 10 giugno 2024, n. 5180).
Il consolidato orientamento della giustizia amministrativa ha ormai definitivamente chiarito l’indispensabilità del soddisfacimento contestuale, sia del requisito c.d. teleologico, sia di quello della comune struttura di impresa, affinché al consorzio possa essere univocamente attribuita la qualifica di consorzio stabile.
Quanto all’elemento teleologico, esso consiste nella “astratta idoneità del consorzio, esplicitamente consacrata nello statuto consortile, di operare con un’autonoma struttura di impresa, capace di eseguire, anche in proprio, ovvero senza l’ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate, le presentazioni previste nel contratto” (TAR Lazio, sede di Roma, sez. III, 6 marzo 2023, n. 3715), ferma restando la facoltà, nei limiti consentiti dal Codice, di poter eseguire le prestazioni anche per il tramite delle singole consorziate.
In virtù della sua configurazione giuridica, infatti, il consorzio stabile può partecipare alle procedure di gara in nome e nell’interesse proprio, oppure anche nell’interesse di tutti o solo di alcuni dei consorziati.
Il Codice dei contratti pubblici, oltre al requisito teleologico, introduce un ulteriore elemento indispensabile, vale a dire la “comune struttura di impresa”, risultando, di conseguenza, elemento indefettibile di tali soggetti la creazione di un’azienda consortile, “intesa nel senso civilistico di complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” (Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2024, n. 266).
Nonostante le dispute giurisprudenziali in merito alla nozione di comune struttura di impresa, il Supremo Consesso (sez. V, 8 gennaio 2024, n. 266) ha chiarito che tale requisito possa conseguirsi per duplice via, “mediante la creazione ex novo di una struttura aziendale con l’assunzione in capo al consorzio di proprio personale unitamente all’acquisizione di propri macchinari, attrezzature e strumenti, con i quali, al pari delle imprese consorziate, dotarsi di capacità tecnico - professionali idonee ad eseguire commesse pubbliche”; ma anche (“rientrandovi nei limiti consentiti dalla nozione civilistica di ‘azienda’ quale ‘complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa’”) “acquisendo la sola disponibilità giuridica di personale e mezzi che, al momento opportuno, il [management] consortile possa organizzare per procedere all’esecuzione diretta del contratto. In quest’ultimo caso, in definitiva, il consorzio potrà attingere dalle singole consorziate il personale, i mezzi e le attrezzature, ma anche, eventualmente, le risorse finanziarie, che, organizzate in maniera originale, consentiranno l’esecuzione diretta del contratto” (Cons. Stato, V, 14 dicembre 2021, n. 8331)”.
Pertanto, indipendentemente dalle previsioni statutarie o degli accordi interni tra le consorziate, ciò di cui necessita il consorzio stabile affinché possa essere riconosciuto come tale è l’effettiva capacità materiale o giuridica di poter predisporre ed organizzare le risorse necessarie alla propria partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.
In definitiva, si tratta di operatori economici dotati di autonoma personalità giuridica rispetto alle consorziate, costituiti in forma collettiva e con causa mutualistica, che operano e partecipano in proprio alle gare, oppure, “in base allo stabile rapporto organico con le imprese associate” giovandosi “senza necessità di ricorrere all’avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del cumulo alla rinfusa” (Consiglio di Stato, sez. V , 28 marzo 2023, n. 3148).
Proprio con riferimento all’ultima modalità di partecipazione sopra descritta, la portata applicativa del cumulo alla rinfusa ha subito un’inaspettata evoluzione, stante il repentino passaggio dalla primigenia formulazione dell’art. 67 d. lgs. n. 36/2023, sino alla versione attualmente in vigore, risultante dalle modifiche apportate al Codice dal d. lgs. n. 209/2024 (c.d. Correttivo al Codice dei contratti pubblici).
La disciplina del Cumulo alla rinfusa nella primigenia formulazione del d.lgs. 36/2023
Per comprendere le modifiche apportate dal Correttivo all’istituto del cumulo alla rinfusa, occorre descrivere l’impostazione liberistica originariamente stabilita dalla primigenia formulazione dell’art. 67 del Codice, anche tenendo conto del fatto che la disciplina in questione trova (ancora) applicazione per tutte le gare indette (o meglio pubblicate) dal 1° aprile 2023 - data in cui le disposizioni codicistiche hanno acquisito, per lo più, efficacia - sino al 1° gennaio 2025, ossia fino alla loro sostituzione per mano del Correttivo stesso.
Pertanto, nel lasso temporale dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2024, l’art. 67, comma 2, d. lgs. n. 36/2023, prescriveva che per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria dovessero essere “computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”, mentre per gli appalti di lavori, detti requisiti avrebbero dovuto essere posseduti e comprovati dagli stessi consorzi “sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”.
Ad un attento osservatore non potrà di certo sfuggire che il generico riferimento normativo alle imprese consorziate avesse determinato, indipendentemente dall’oggetto della gara (sia nell’ambito di appalti di servizi e forniture, sia in quelli di lavori), la massima espansione applicativa del cumulo alla rinfusa, ben potendo il consorzio dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti dalla normativa di gara, sommando quelli posseduti in proprio a quelli delle consorziate, anche non designate.
Come riconosciuto dal Consiglio di Stato (sez. V, 29 settembre 2023, n. 8592), “il nuovo Codice dei contratti pubblici ha ammesso, in sostanza, in maniera generica e senza limitazioni, il ‘cumulo alla rinfusa’ anche all’art. 67, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023, il quale ha espressamente previsto che “per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”.
La volontà del Legislatore trovava fondamento e giustificazione in ragione del fatto che fosse il consorzio stabile (e non già ciascuna delle singole imprese consorziate) ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e, per l’effetto, a dover dimostrare il possesso dei relativi requisiti partecipativi, anche mediante il cumulo dei requisiti delle imprese consorziate, a prescindere dal fatto che le stesse fossero designate o meno in gara per l’esecuzione del contratto.
La forza innovatrice della modifica normativa può essere valutata con pienezza anche tenendo conto della norma di interpretazione autentica - pertanto avente efficacia già dal 1° aprile 2023, in quanto sottratta al regime di efficacia differita che riguarda le altre disposizioni del Codice - di cui all’art. 225, comma 13, d. lgs. n. 36/2023, che prevede che “gli articoli 47, comma 1, 83, comma 2, e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpretano nel senso che, in via transitoria, relativamente ai consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c), del medesimo codice, ai fini della partecipazione alle gare e dell’esecuzione si applica il regime di qualificazione previsto dall’articolo 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e dagli articoli 81 e 94 del regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L’articolo 47, comma 2- bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpreta nel senso che, negli appalti di servizi e forniture, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti dal bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati in gara”.
In buona sostanza, il Legislatore è intervenuto, disciplinando il cumulo alla rinfusa non solo pro futuro, ma anche dirimendo, in modo coerente, l’annosa questione relativa alla corretta applicazione dello stesso con riferimento alla disciplina contenuta nel d. lgs n. 50/2016, confermando che anche per le gare indette sotto la vigenza del vecchio Codice, i consorzi stabili potessero partecipare alle gare d’appalto sommando i propri requisiti tecnici ed economici a quelli delle consorziate (anche non designate).
Proprio alla luce di tale norma interpretativa e chiarificatrice, il Consiglio di Stato (sez. V, 3 gennaio 2024, n. 71) ha precisato, definendo una controversia assoggetta alla normativa del d. lgs. n. 50/2016, che:
a) la qualificazione è richiesta in capo al consorzio stabile e non in capo alle singole consorziate, atteso che la qualificazione delle singole consorziate rileva solo ai fini del cumulo alla rinfusa e per verificare che il consorzio stabile sia qualificato;
b) una volta che si accerti che il consorzio stabile è qualificato, non rileva verificare la qualificazione o meno delle singole consorziate;
c) il cumulo alla rinfusa previsto dal comma 1 dell’art. 47 determina un avvalimento ex lege che si deve intendere bidirezionale alla luce del comma 2 della stessa norma;
d) la esecuzione diretta o tramite consorziate, con responsabilità solidale, presuppone appunto un avvalimento ex lege che opera in senso bidirezionale;
e) non ha alcuna rilevanza che la consorziata esecutrice non sia qualificata, perché da un lato rileva ed è richiesta solo la qualificazione del consorzio, dall’altro lato se il consorzio esegue tramite consorziata non qualificata, è responsabile in solido, ossia il consorzio opera come una ausiliaria ex lege”.
L’effetto pratico generato da una disciplina del cumulo alla rinfusa di tal genere è facilmente intuibile: riconoscere in capo al consorzio la facoltà di affidare l’esecuzione della commessa anche a consorziate prive, totalmente o solo in parte, dei requisiti speciali prestabiliti dalla lex specialis.
Le modifiche introdotte dal Correttivo all’istituto del Cumulo alla rinfusa
L’entrata in vigore del c.d. Correttivo al Codice (1° gennaio 2025) segna una drastica modifica, in senso restrittivo, all’ambito di applicazione del cumulo alla rinfusa, essendo chiara la volontà del Legislatore di tornare sui propri passi, con mirati interventi riguardanti le modalità di partecipazione (rectius qualificazione) dei consorzi stabili alle gare di lavori, atteso che l’art. 67, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 36/2023, continua a prevedere, in perfetta continuità con la pregressa normativa, che i requisiti di capacità tecnica e finanziari “per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”.
Se, dunque, la disciplina per quanto concerne gli appalti di servizi e forniture non presenta alcuna novità, profonde modifiche sono intervenute con riguardo agli appalti di lavori, dato che il Legislatore ha ritenuto opportuno intervenire sull’originaria disciplina dell’art. 67 del d.lgs. n. 36/2023, tenendo ben distinta la fattispecie in cui il consorzio stabile esegua le lavorazioni richieste dalla Stazione appaltante esclusivamente con la propria struttura, senza designare alcuna impresa esecutrice, dall’ipotesi, affatto sovrapponibile alla predetta, in cui le lavorazioni siano materialmente realizzate dalle consorziate indicate in sede di gara dal consorzio.
- Nel primo caso, infatti, l’art. 67, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che “per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate”, non subendo, quindi, il cumulo alla rinfusa alcuna limitazione applicativa.
- Ben diversa (forse anche comprensibilmente) è la seconda ipotesi, dato che l’art. 67, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023 attualmente in vigore prescrive che “per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104”.
Dunque, nell’ipotesi di appalti i lavori, laddove il consorzio stabile designi talune consorziate per l’esecuzione delle prestazioni, le stesse debbono essere qualificate per la quota parte di lavoro ad esse affidate, anche facendo ricorso, laddove non in possesso dei requisiti necessari, all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 104, d. lgs. n 36/2023.
La ratio del sistema di qualificazione ridisegnato dal Legislatore non abbisogna di particolari spiegazioni, essendo chiara la volontà del predetto di assicurare che le consorziate designate per l’esecuzione dei lavori siano in possesso delle richieste qualificazioni, non potendo il consorzio stabile divenire una modalità di partecipazione alle gare in grado di legittimare l’esecuzione di prestazioni da parte di soggetti sprovvisti delle competenze e dei mezzi necessari.
In definitiva, la soluzione proposta con il Correttivo appare un compromesso, forse frastagliato, ma di certo volto a riconoscere le peculiarità del consorzio stabile, senza, tuttavia, che il regime di specialità per esso delineato in termini di dimostrazione del possesso dei requisiti speciali possa andare ad inficiare le necessarie istanze di affidabilità che debbono contraddistinguere gli esecutori di lavori pubblici.
avv. Amedeo Cicognani
Studio Legale Zoppellari e Associati
Esclusiva web: prova gratis per 10 giorni
Attivando subito la prova dei nostri servizi potrai utilizzare la piattaforma Telemat per:
- Ricevere avvisi quotidiani sulle nuove gare di tuo interesse
- Analizzare velocemente tutti i documenti
- Ricercare all'interno del nostro archivio
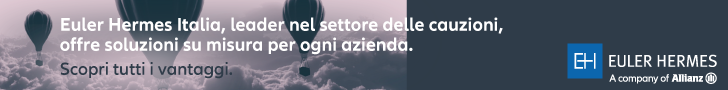


 Prova gratis ora
Prova gratis ora 
