- Homepage / News / Normativa e Prassi / Partenariato Pubblico Privato e Codice appalti (Dlgs 36/2023)
Esclusiva web: prova gratis per 10 giorni
Attivando subito la prova dei nostri servizi potrai utilizzare la piattaforma Telemat per:
- Ricevere avvisi quotidiani sulle nuove gare di tuo interesse
- Analizzare velocemente tutti i documenti
- Ricercare all'interno del nostro archivio
Articoli recenti
- Cumulo alla rinfusa: dal nuovo Codice dei contratti pubblici al Correttivo
- Partenariato Pubblico Privato e Codice appalti (Dlgs 36/2023)
- Il soccorso istruttorio nel Nuovo Codice Appalti: tipologie, limiti e novità
- La Digitalizzazione dei Contratti Pubblici nel Codice Appalti
- L’equo compenso negli appalti pubblici: legge 49/2023
Partenariato Pubblico Privato e Codice appalti (Dlgs 36/2023)

Il Partenariato Pubblico-Privato (PPP): definizione e vantaggi
Con la locuzione “Partenariato Pubblico-Privato” (PPP) si indica una vasta gamma di modelli di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato volti a finanziare, realizzare e gestire infrastrutture oppure a fornire servizi d’interesse generale.
L’intervento dei soggetti privati nel finanziamento, realizzazione e gestione dei progetti pubblici permette di perseguire, per il tramite di operazioni ben strutturate, finalità eterogenee, tra le quali:
- usufruire del know-how e della expertise professionale degli Operatori economici privati con un conseguente miglioramento dell’efficienza nella gestione, di qualità delle opere e di efficacia dei servizi resi;
- trasferire, in modo trasparente, proporzionato e mirato, parte dei rischi del progetto al settore privato;
- condividere conoscenze, competenze, risorse e rischi tra settore pubblico e settore privato;
- superare i vincoli sulla spesa pubblica e sui saldi di bilancio.
Il PPP nel Codice dei contratti pubblici
L’attuale Codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. - operando un’inversione sistematica rispetto al precedente impianto normativo (D.lgs. n. 50/2016) - ha il merito di dare una struttura compiuta all’istituto del partenariato pubblico-privato, comprensiva sia del partenariato pubblico-privato contrattuale, sia del partenariato pubblico-privato istituzionale.
Il libro IV del Codice si apre, difatti, con l’art. 174 che, riconoscendo la complessità dell’istituto, definisce il partenariato pubblico privato come una “operazione economica” che si sviluppa in un rapporto contrattuale di lungo periodo, nel quale “la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata”, su cui deve essere allocato il rischio operativo e cui “spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione”.
Le quattro caratteristiche del Partenariato Pubblico Privato
Più nel dettaglio, l’articolo 174 precisa che, affinché si possa parlare di operazione di partenariato pubblico -privato devono ricorrere congiuntamente le seguenti quattro caratteristiche:
- a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati deve instaurarsi un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un obiettivo di interesse pubblico;
- b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata;
- c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;
- d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.
Il nuovo Codice ha evidenziato l’alternatività del PPP rispetto all’appalto, prevedendo la disciplina del partenariato e delle concessioni nel Libro IV, senza effettuare rinvii alle disposizioni sugli appalti, come avveniva invece nell’abrogato Codice (di cui al D.lgs. n. 50/2016), creando così un corpus normativo autonomo rispetto agli appalti pubblici.
Partenariato Pubblico Privato contrattuale e istituzionalizzato
Come anticipato, il Codice, seguendo l’impostazione europea, all’art. 174 distingue due categorie di PPP che si differenziano in base agli strumenti giuridici attraverso i quali si realizzano tali operazioni: PPP contrattuale e PPP istituzionalizzato.
- Il primo, definito al comma 3 dell’art. 174 “comprende le figure della concessione, anche nelle forme della finanza di progetto, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al comma 1 e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.
L’affidamento e l’esecuzione dei relativi contratti sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV della Parte II. Le modalità di allocazione del rischio operativo, la durata del contratto di partenariato pubblico-privato, le modalità di determinazione della soglia e i metodi di calcolo del valore stimato sono disciplinate dagli articoli 177, 178 e 179”.
- Il comma 4 dello stesso articolo, invece, definisce il PPP di tipo istituzionale che “si realizza attraverso la creazione di un ente partecipato congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica ed è disciplinato dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e dalle altre norme speciali di settore”.In altri termini, il PPP di tipo istituzionale si distingue rispetto al primo per via della necessaria creazione di un’entità terza, riconducibile congiuntamente sia al partner privato che al soggetto pubblico, e di cui costituisce l’esempio più noto la società mista, con compiti di assicurare la fornitura di un’opera o di un servizio a favore della collettività.
A conferma della complessità dell’istituto vi è l’ultimo comma dell’art. 174, il quale stabilisce che i contratti di PPP possono essere stipulati solo da “enti concedenti qualificati ai sensi dell’articolo 63”, limitando di fatto la possibilità per gli enti concedenti non qualificati di farvi ricorso direttamente. In buona sostanza, il Legislatore ha ritenuto che una materia particolarmente complessa non possa che essere trattata da soggetti particolarmente competenti.
Le species del PPP: concessione, locazione finanziaria e contratto di disponibilità
Con il nuovo Codice il Partenariato Pubblico-Privato viene eletto come schema generale di contratto pubblico alternativo all’appalto e che precede la disciplina delle figure contrattuali tipiche, quali la concessione di lavori e di servizi, la locazione finanziaria e il contratto di disponibilità.
Peraltro, tale impostazione viene chiarita anche nella Relazione Illustrativa al Codice, la quale sul punto precisa che nel libro IV si è voluto ribadire il principio di atipicità e non esclusività delle forme contrattuali partenariali: “In forza della capacità generale di diritto privato, l’amministrazione può infatti forgiare anche schemi negoziali diversi da quelli nominati, purché aderenti, nei contenuti, alla regolazione pubblicistica contenuta nel libro IV”.
La definizione delle species sopra elencate è rinvenibile rispettivamente alle lett. c) ed i) al comma 1 dell’art. 2 dell’Allegato I.1 e all’art. 196 del Codice.
Ai sensi della lett. c), i contratti di concessione sono “contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo”.
La lett. i) dello stesso comma, così come modificato dal D.lgs. n. 209/2024 (cd. Decreto correttivo), definisce il contratto di disponibilità come “il contratto con il quale un operatore economico si obbliga, verso un corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a realizzare, riqualificare o rifunzionalizzare e a concedere in godimento all'amministrazione aggiudicatrice un'opera, destinata ad uso pubblico o di interesse pubblico. L'operatore economico garantisce il miglior godimento dell'opera, mantenendola in stato da servire all'uso convenuto ed eliminandone a proprie spese i vizi, anche sopravvenuti. Il contratto può prevedere il trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione, verso il pagamento di un corrispettivo ulteriore. Per la conclusione e l'esecuzione del contratto di disponibilità l'amministrazione può fare ricorso a fondi comuni di investimento o società immobiliari e può prevedere il conferimento da parte dell'amministrazione di immobili in tali fondi o in tali società, a titolo di corrispettivo totale o parziale, tenuto conto del relativo valore di mercato, da riqualificare mediante l'utilizzo di risorse finanziarie private e da destinare ad uso pubblico o di interesse pubblico”.
Infine, l’art. 196 del Codice specifica che “le amministrazioni aggiudicatrici possono fare ricorso al contratto di locazione finanziaria - che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale del contratto medesimo - per la realizzazione, l’acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità”.
Attraverso tale operazione l’amministrazione aggiudicatrice acquisisce la disponibilità dell’opera messa a disposizione dal privato finanziatore (che ne resta proprietario), a fronte del pagamento di un canone periodico per la durata del contratto, al termine del quale l’ente utilizzatore ha la facoltà di acquisirne la proprietà pagando un riscatto.
Valutazioni preliminari per il ricorso al Partenariato Pubblico Privato
L’articolo 175 del Codice dei contratti pubblici prevede l’adozione di un programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato. Come evidenziato nella Relazione Illustrativa, la finalità di tale previsione è anzitutto quella di garantire la massima trasparenza nei confronti degli Operatori economici, degli investitori istituzionali e della collettività, con l’ulteriore auspicio che la pubblicazione di tale programma riesca anche a stimolare un dibattito pubblico con riguardo ai progetti di maggior rilievo sociale.
Il ricorso al PPP deve essere preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità, la quale deve altresì incentrarsi sull’idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto costi-benefici, nonché sull’efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, sulla capacità di indebitamento dell’ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale.
Come è stato precisato in sede di Relazione Illustrativa, in un’ottica di massima efficienza, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità dovrà porre a confronto la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato nell’arco dell’intera durata del rapporto con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente.
La norma mira a garantire che la scelta di ricorrere allo strumento del PPP sia ponderata e fondata su approfondite riflessioni e considerazioni in ordine alla sua convenienza e fattibilità.
A completamento della fase relativa alla valutazione preliminare, nonché per quanto attiene alla predisposizione dello schema di contratto di PPP, ai commi 3 e 4 dell’art. 175, sono disciplinati una serie di meccanismi funzionali a supportare gli enti concedenti per le opere o servizi particolarmente complessi, come i pareri resi dal CIPESS, dal DIPE e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Forme speciali di partenariato nel Codice dei contratti pubblici
Il Codice dei contratti pubblici prevede, altresì, forme speciali di partenariato di cui all’art. 134, relativamente al settore dei beni e delle attività culturali.
In particolare, il comma 2 di tale articolo prevede che, per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le Regioni e gli Enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati.
Queste forme speciali di partenariato sono dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato.
Tali forme speciali di PPP, che prevedono uno strumento maggiormente flessibile per coinvolgere i soggetti privati, anche senza scopo di lucro, nella gestione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali si attiva anche attraverso la sottoscrizione di accordi pubblico-privati che vedono spesso la partecipazione degli Enti del Terzo Settore.
In proposito di particolare interesse è il recente Decreto del Ministero della Cultura - Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, del 1 agosto 2025 n. 79 recante “Linee guida in materia di Partenariato Speciale Pubblico - Privato per gli istituti e i luoghi della cultura”, emanate in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 134 comma 1 e 2 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 , anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati di cui al Codice del beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42) ed al medesimo Codice dei contratti pubblici.
Avv. Rosalba Cori e Avv. Tania Rea - Studio Legale Piselli&Partners
Esclusiva web: prova gratis per 10 giorni
Attivando subito la prova dei nostri servizi potrai utilizzare la piattaforma Telemat per:
- Ricevere avvisi quotidiani sulle nuove gare di tuo interesse
- Analizzare velocemente tutti i documenti
- Ricercare all'interno del nostro archivio
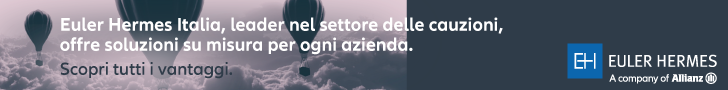


 Prova gratis ora
Prova gratis ora 
